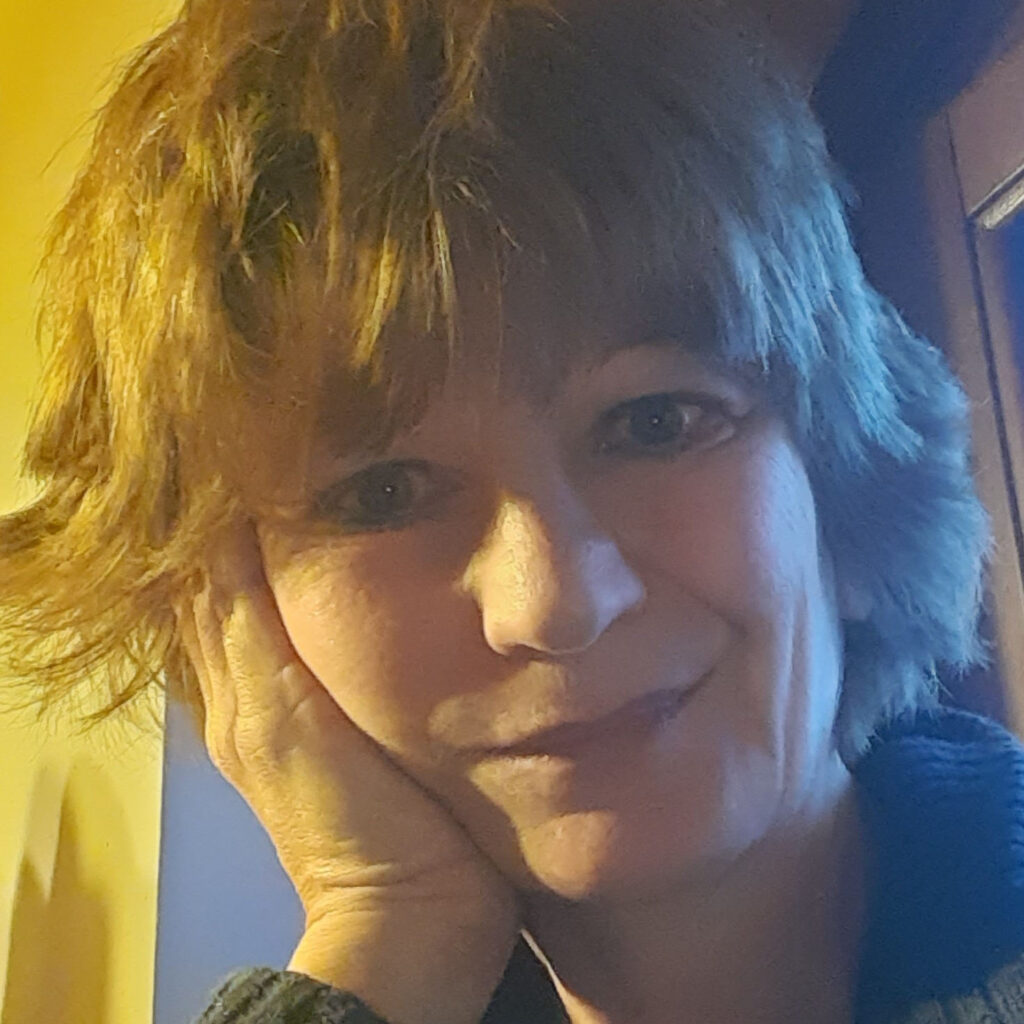L’IRREVERSIBILE SQUILIBRIO TRA I POTERI DELLO STATO
di Gian Domenico Caiazza* «Chiunque abbia potere è portato ad abusarne; egli arriva sin dove non trova limiti (…) Perché non si possa abusare del potere occorre che il potere arresti il potere». Così Montesquieu ragionava, nel 1748, nel porre a fondamento della idea moderna di Stato democratico il principio della separazione dei poteri. Ecco allora che il potere legislativo «fa delle leggi per sempre o per qualche tempo, e corregge o abroga quelle esistenti»; il potere esecutivo «fa la pace o la guerra, invia o riceve delle ambascerie, stabilisce la sicurezza, previene le invasioni»; il potere giudiziario, infine, “bouche de la lois”, «punisce i delitti o giudica le liti dei privati». Naturalmente le idee evolvono, si adeguano alle mutazioni sociali e politiche, ma il principio della separazione dei poteri, della limitazione reciproca tra di essi, resta il caposaldo, direi la precondizione di sopravvivenza del sistema democratico. Regolarmente, dove esso è messo in discussione, si teme per la sorte stessa della democrazia. Le cronache statunitensi di queste prime settimane di Presidenza Trump, ad esempio, ne sono la dimostrazione lampante ed allarmante, con un potere esecutivo (il Presidente) che forza e scavalca sia il potere legislativo (con la adozione di centinaia di “ordini esecutivi”), sia quello giudiziario (addirittura ignorando statuizioni non gradite e non condivise della Suprema Corte). In casa nostra, sebbene con forme del tutto diverse, l’equilibrio è saltato nei primi anni ’90, e non c’è più verso di recuperarlo. È bastata una indagine giudiziaria sulla certamente assai diffusa corruzione del potere politico, accompagnata da un formidabile consenso popolare e da una irresponsabile, acritica copertura mediatica, per attribuire all’ordine giudiziario magistratuale un potere di condizionamento e di interdizione verso gli altri due poteri che non ha equivalenti in nessun altro sistema democratico. L’immagine simbolo, lo ricordiamo tutti, fu quella dei magistrati del pool milanese in TV che affermano la necessità che un legittimo provvedimento di un governo democraticamente eletto, giusto o sbagliato che fosse non importa, venisse ritirato perché da essi non condiviso, ottenendone la revoca a furor di popolo. Un atto – a prescindere dalle intenzioni di chi lo realizzò – tecnicamente eversivo, che ha segnato in modo irreversibile l’equilibrio tra poteri dello Stato nel nostro Paese. Perfino in questi mesi, nei quali una solida maggioranza parlamentare sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo) determinata a portare a termine la più avversata (dalla magistratura) riforma dell’ordinamento giudiziario nella storia Repubblicana, i segni della debolezza del potere politico, intimorito e condizionato dal potere giudiziario, ci giungono copiosi. È di pochi giorni fa la sorprendente iniziativa, assunta direttamente dalla presidente Giorgia Meloni, di fermare l’iter della proposta di legge di istituzione della giornata in onore delle vittime degli errori giudiziari, individuata nella simbolica data del 17 giugno, quella nella quale fu arrestato Enzo Tortora nell’ormai lontano 1983. Le cronache riferiscono la testualità della motivazione addotta dalla Presidente del Consiglio: «Non diamo altri pretesti ai giudici fino alla approvazione della riforma sulla separazione delle carriere». Dietro le apparenze di una decisione dettata da realismo strategico, di chi intenda in questo modo rendere più agevole la strada di quella fondamentale riforma costituzionale, si affaccia in realtà, nitidissima, la impressionante fotografia del patologico rapporto tra potere politico e potere giudiziario in Italia. Da un lato, infatti, non esiste alcun nesso logicamente plausibile tra questa riforma costituzionale e quella proposta di legge sulle vittime degli errori giudiziari; dall’altro, non si comprende esattamente quale pretesto potrebbe mai cogliere un soggetto – la magistratura associata – che non ha (non dovrebbe avere!) né titoli né ragioni per interloquire su una simile iniziativa politica. Il fatto che l’ANM abbia subito manifestato a proposito di essa le proprie obiezioni critiche, con motivazioni peraltro assai discutibili, non si comprende in qual modo potrebbe incidere sul percorso della riforma ordinamentale, anche nella prospettiva della quasi certa campagna referendaria successiva alla sua auspicabile approvazione. Nelle intenzioni, la Presidente Meloni vuole prevenire argomenti polemici, intesi a rafforzare, da parte delle toghe, l’idea di una maggioranza politica ispirata da sentimenti di ostilità nei confronti della Magistratura. Ma è proprio questo il punto. Le vittime di un errore giudiziario sono tali in forza di una valutazione operata dalla stessa magistratura, che riconosce l’errore giudiziario, o la ingiusta detenzione, all’esito di un procedimento che essa stessa gestisce in modo sovrano, ed in assoluta autonomia e indipendenza. Errori giudiziari ed ingiuste detenzioni sono definiti tali non dalla politica, con arbitrarie valutazioni polemiche, ma dai giudici della Repubblica, con sentenze definitive pronunziate in nome del popolo italiano. La scelta dello Stato di esprimere, con una giornata celebrativa annuale, la propria rammaricata vicinanza a chi ha subito una così grave ingiustizia, è una scelta schiettamente politica, sulla quale la magistratura, in un normale e non alterato sistema di divisione dei poteri, non avrebbe titolo alcuno per manifestare riserve o, peggio ancora, risentimento. D’altronde, la speciosa critica avanzata da ANM, secondo la quale si dovrebbe allora celebrare anche la giornata per le vittime -fu fatto questo esempio- della malasanità (le quali però, diversamente che per gli errori giudiziari, ne vedono puniti i responsabili!) dà proprio il segno di quanto sia deteriorato quel delicato equilibrio costituzionale. Da un lato il potere giudiziario pretende, come se fosse la cosa più normale del mondo, di svolgere una funzione di interdizione critica e quasi sindacale su qualsiasi iniziativa legislativa che possa anche solo richiamare l’attenzione sugli esiti e sulla qualità dell’esercizio della giurisdizione, assumendo alla stregua di una indebita aggressione qualsiasi valutazione ad essa non gradita; dall’altro, la politica riconosce, nei fatti, pieno fondamento a questa assurda pretesa, mostrando anzi di temerne le conseguenze, e confessando così, nel modo più clamoroso e sorprendente, la propria soggezione verso il potere giudiziario, ed in definitiva la sua disarmata debolezza. Che non scopriamo certo adesso, ma che francamente mai avremmo immaginato potesse spingersi a tanto. *Past President UCPI – Direttore PQM (Editoriale pubblicato in Ante Litteram 1-aprile 2025)
L’IRREVERSIBILE SQUILIBRIO TRA I POTERI DELLO STATO Leggi tutto »