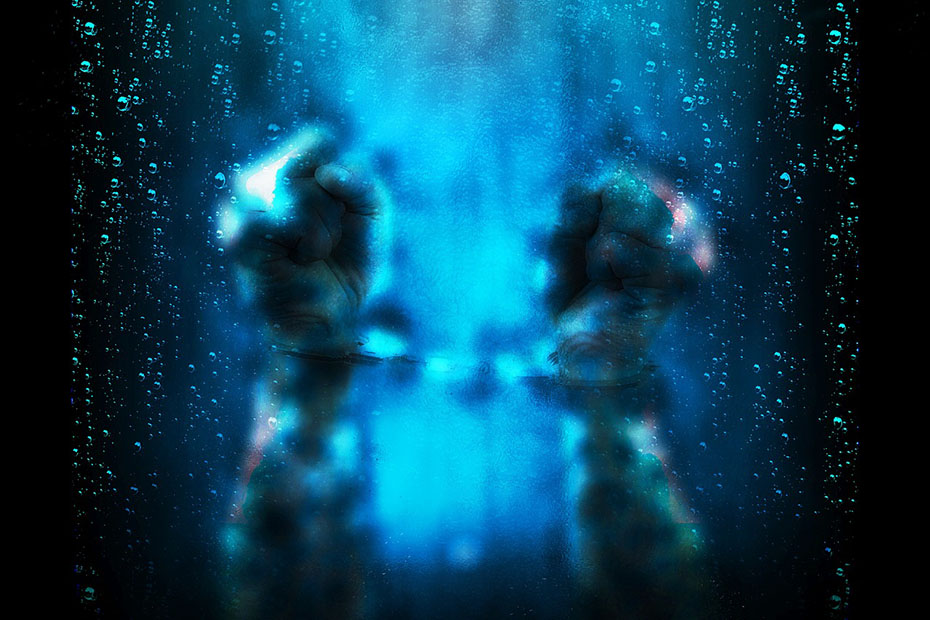RIPARAZIONE PER (IN)GIUSTA DETENZIONE: I LIMITI AL RISTORO PER LA CUSTODIA CAUTELARE “AL DI QUÀ” DEL RAGIONEVOLE DUBBIO
di Domenico Commodaro[1] e Gessica Veronica Golia[2] Sommario 1. Inquadramento normativo – 2. Profili procedurali – 3. L’ingiustizia della custodia nella forma o nella sostanza – 3.1. L’ingiustizia formale – 3.2. L’ingiustizia sostanziale – 3.2.1. Gli incerti contorni della colpa grave – 3.2.2. Riparazione e diritto al silenzio – 3.3. Erroneo ordine di esecuzione – 4. Il quantum dell’indennizzo. 1. Inquadramento normativo. La prima elaborazione di istituti di natura riparatoria a tutela dei cittadini, rispetto all’operato delle Autorità, si deve alla dottrina illuministica e, in particolare, ai criminalisti francesi che ne individuavano il fondamento nel patto sociale, fonte, com’è noto, di obbligazioni reciproche tra lo Stato e i cittadini, donde una responsabilità sostanzialmente “contrattuale”. Senza indugiare in poco utili ricostruzioni storiche, è sufficiente ricordare che l’addentellato costituzionale della riparazione in esame si individua nell’art. 24 co. 4 Cost. e che l’istituto odierno della riparazione per ingiusta detenzione è disciplinato dagli artt. 314 e 315 c.p.p. Tale disciplina è stata introdotta dal Legislatore italiano nel 1988, in ottemperanza all’obbligo posto dall’art. 5 par. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a mente del quale «Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione». Detto principio fa eco all’art. 9 par. 5 del Patto Internazionale dei diritti civili e politici[3] («Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha pieno diritto a un indennizzo»), il quale, a sua volta, riecheggia nell’art. 85 dello Statuto della Corte Penale internazionale (“Chiunque sia stato vittima di un arresto o di una detenzione illegale ha diritto a un risarcimento effettivo”). Dunque, per fronteggiare l’ineliminabile alea che caratterizza la giurisdizione penale, ogni ordinamento è tenuto a dotarsi di strumenti rimediali che, ex post, garantiscano una qualche forma di ristoro al cittadino che finisca per l’incappare in tale alea. Con l’istituto di cui agli artt. 314 e 315 del codice di rito, l’Italia, dunque, segue tali coordinate sovranazionali, tuttavia discostandosene, a ben vedere, in una duplice direzione: per un verso, ampliandone l’ambito di applicazione (con la figura della c.d. ingiustizia sostanziale); per altro verso, ponendo requisiti più stringenti per l’effettiva concessione del ristoro[4]. 2. Profili procedurali. La giurisprudenza non ha esitato a definire la riparazione per ingiusta detenzione come un’azione sostanzialmente civilistica, che si svolge in sede penale per ragioni di opportunità. Sul piano procedurale, la domanda deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro 2 anni dalla data di irrevocabilità della sentenza di proscioglimento (o di condanna, nel caso di custodia cautelare sofferta in eccesso rispetto alla pena irrogata), o dalla data di notifica del provvedimento di archiviazione. Competente è la Corte d’Appello penale del distretto in cui si trova l’Autorità Giudiziaria che ha emanato il provvedimento applicativo della misura cautelare, di cui si chiede il ristoro; il procedimento si svolge con il rito camerale di cui all’art. 127 c.p.p. A proposito dei soggetti legittimati, occorre aggiungere che nel caso in cui l’interessato sia deceduto prima della irrevocabilità della sentenza assolutoria, l’indennizzo – in forza del rinvio operato dall’art. 314 c.p.p. alla disciplina dell’errore giudiziario – può essere successivamente richiesto anche dai congiunti elencati nell’art. 644, comma I, c.p.p., i quali sono legittimati iure proprio, e non iure hereditario, a presentare la relativa domanda[5]. Non differente è l’ipotesi in cui, in luogo di una sentenza di assoluzione, venga in rilievo un provvedimento di archiviazione, richiamato in subiecta materia dal comma 3 dell’art. 314 c.p.p.[6] Fa eccezione, invece, l’ipotesi in cui l’interessato sia deceduto prima che il giudice di merito pervenga ad una sentenza assolutoria nei suoi confronti, sicché, con riferimento alla sua posizione, il processo si sia concluso con un provvedimento di archiviazione per morte del reo. Con riferimento a tali evenienze, la Corte Costituzionale, con sentenza 23 dicembre 2004 n. 413, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della riparazione per ingiusta detenzione, ha affermato il principio per cui la di-sposizione di cui all’art. 314 co. 3 c.p.p. deve essere letta nel senso che “il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione opera anche in favore degli eredi dell’indagato la cui posizione sia stata archiviata per ‘morte del reo’, qualora nella sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata nei confronti dei coimputati risulti accertata l’insussistenza del fatto a lui addebitato” [7](v. Corte Cost. n. 413/2004). Orbene, a proposito degli attori coinvolti, a latere debitoris, sia consentito rilevare come la difesa erariale, che rappresenta ex lege il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella prassi, sia solita non opporsi alla domanda di equa riparazione (quale che sia la vicenda sottesa all’istanza, quali che siano i fatti di reato contestati, quale che sia il compendio probatorio)[8], limitandosi a chiedere la integrale compensazione delle spese[9]. Maggiormente significativo si rivela invece, solitamente, l’apporto conferito al giudizio dalla Procura Generale. 3.L’ingiustizia della custodia nella forma o nella sostanza. Il legislatore italiano ha ideato una forma di ristoro per rimediare alla privazione della libertà personale, subita per l’applicazione di una misura cautelare che sia stata inflitta in assenza dei presupposti previsti dalla legge (c.d. ingiustizia formale), o a cui, comunque, abbia fatto seguito una sentenza di assoluzione (c.d. ingiustizia sostanziale), purché l’imputato non abbia dato causa o concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave. La riparazione di cui trattasi ha natura di indennizzo, e non già di risarcimento (per come pure in passato talvolta è stato sostenuto), non essendo originata da un atto illecito: diversamente opinando, peraltro, sul ricorrente peserebbe un onere probatorio decisamente gravoso, dovendo provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, di cui all’art. 2043 c.c.[10]. D’altro canto, potrebbe ravvisarsi un atto viziato solo nell’ordinanza di custodia cautelare adottata in difetto dei presupposti di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p., che integra la c.d. ingiustizia formale, con cui inizierà la nostra breve trattazione. 3.1. L’ingiustizia formale. Ai sensi dell’art. 314 co. II c.p.p., si definisce affetta da c.d. “ingiustizia formale” la custodia cautelare disposta con un provvedimento emesso o mantenuto in assenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt.