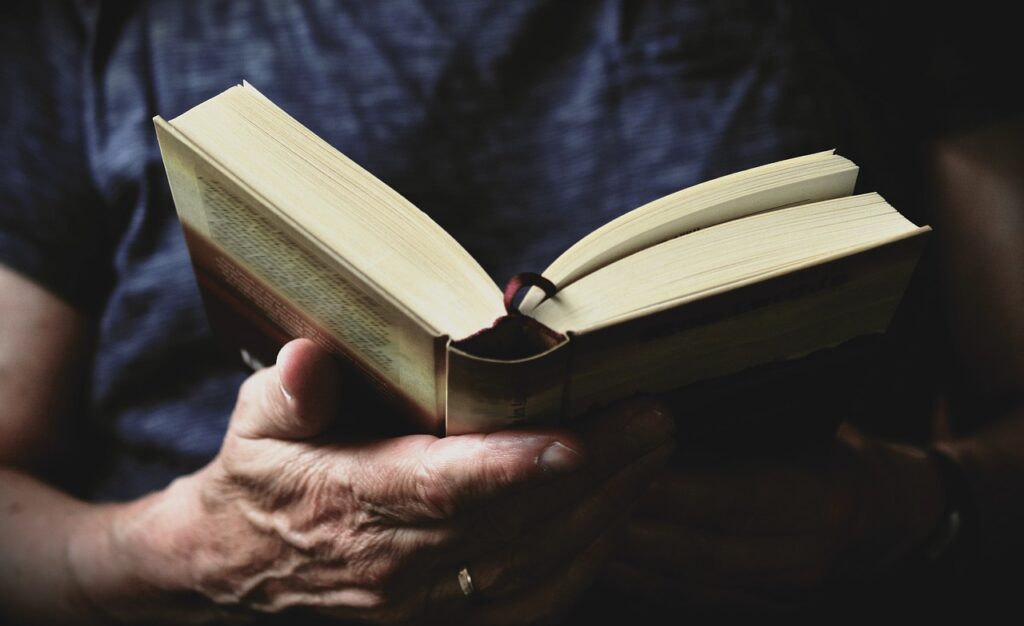BREVE NOTA A CASSAZIONE 1 OTTOBRE 2024, N. 36531: IMPUTABILITÀ E DISTURBO BIPOLARE, I PRINCIPI DELLA “RASO”
di Marta Staiano* – La recente sentenza della Corte di Cassazione, in quota di interesse, accoglie il ricorso dell’imputata dichiarata responsabile per il reato di molestie, confermando il principio di diritto per il quale «il giudice è tenuto ad accertare la capacità di intendere e di volere dell’imputato anche d’ufficio, quando vi siano elementi che facciano dubitare della sua imputabilità». La Corte è nuovamente chiamata a pronunciarsi su una tematica di estrema complessità, quale l’ampiezza dell’infermità mentale riferita all’esclusione dell’imputabilità, nonché il novero indiziario di dati che obbligano il giudice al suo accertamento. S’offre il destro a brevi puntualizzazioni sul tema. Già da tempo si afferma in dottrina che l’imputabilità è al tempo stesso nozione empirica e normativa[1]: in tal senso, pur avendo il legislatore previsto parametri predeterminati questi sono da ancorarsi ai progressi scientifici in tema di eziogenesi e manifestazione della patologia psichiatrica, dovendo il giudice soffermarsi con precipuo scrutinio del tema ogni qual volta ricorrano elementi da cui potenzialmente desumere una “deficienza” mentale, purché ne sia dimostrato il nesso eziologico con il fatto di reato. Risemantizzare è il luogo di costruzione dell’ermeneutica. In tal senso, le Sezioni Unite del 2005 – ricorrente Raso – con sentenza n. 9163, depositata in data 8 marzo 2005, si esprimevano compiutamente sui confini del concetto di infermità, ampliandone sensibilmente la portata: «anche i disturbi della personalità, come quelli da nevrosi e psicopatie, possono costituire causa idonea ad escludere o scemare grandemente, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere di un soggetto agente ai fini degli artt. 88 e 89 c.p., sempre che siano di consistenza, rilevanza, gravità e intensità tali da concretamente incidere sulla stessa». «Il concetto di infermità, quindi, si allarga, fino a comprendere non solo le psicosi organiche, ma anche i disturbi morbosi dell’attività psichica, come le psicopatie, le nevrosi, i disturbi dell’affettività: oggetto dell’indagine, quindi, non è più la persona – corpo, ma la persona – psiche». Nella evenienza sottoposta per individuazione di principio di diritto, le Sezioni Unite hanno annullato con rinvio la sentenza censurata: aveva erroneamente escluso il vizio parziale di mente sul rilievo che il disturbo paranoide dal quale, secondo le indicazioni della perizia psichiatrica, risultava affetto l’autore dell’omicidio, non rientrava tra le alterazioni patologiche clinicamente accertabili, corrispondenti al quadro di una determinata malattia psichica, per cui, in quanto semplice “disturbo della personalità”, non integrava quella nozione di “infermità” presa in considerazione dal codice penale. Al contrario la Corte, annullando con rinvio la sentenza impugnata, apriva la strada alla considerazione dei disturbi di personalità in materia di imputabilità, ripudiando la tradizionale concezione mono-causale di malattia. Per converso, non assumono rilievo ai fini della imputabilità le “anomalie caratteriali” o “disarmonie della personalità”, nonché gli “stati emotivi e passionali”, che non rivestano i suddetti connotati di inesione alla capacità di autodeterminazione del soggetto agente[2]. L’approdo convincente è in un “paradigma integrato” di malattia mentale – già da tempo sostenuto dalla scienza psichiatrica – che affianca alla diagnosi nosografica altri moduli interpretativi: viene inoltre riconosciuta la natura di “infermità”, rilevante in termini giuridici, anche ai disturbi dell’affettività e ai disturbi di personalità[3], sempre che essi abbiano influito in maniera significativa sulla funzionalità dei procedimenti intellettivi e volitivi del soggetto agente. Si riconosce, in altri termini, l’influenza sulla malattia mentale tanto di variabili biologiche, quanto di fattori extrabiologici, così recependosi la multifattorialità sia con riguardo alla genesi che al decorso della patologia[4]. È d’uopo precisare che, sebbene la sentenza Raso abbia ridisegnato i confini dell’infermità mentale oltre i tradizionali parametri organicistici, estendendone la portata anche ai disturbi di personalità (et altro) non inquadrabili nei rigidi margini della nosografia, la stessa Corte si mantiene ferma nel puntualizzare che questi debbano essere di gravità e intensità tali da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere: si dice di «disturbo idoneo a provocare una situazione di assetto psichico incontrollabile e ingestibile […] che renda l’agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente, liberamente autodeterminarsi»[5]. Gravità e intensità diventano quindi per la Corte parametri di riferimento per tracciare una linea di confine, quindi discernere tra i disturbi che influenzano le capacità dell’individuo e quelli che rimangono irrilevanti in tema di imputabilità: così la “Raso” indica una terza via oltre le due antecedenti contrastanti visioni del disturbo di personalità e dell’affettività: l’una volta a ricondurre i disturbi in questione nell’alveo delle patologie della mente, l’altra nell’opposto perimetro delle c.d. anomalie non patologiche della personalità. Epperò, la sentenza in esordio significata riceve l’attenzione del giurista per tre ordini di ragioni: poiché aderisce al noto principio di diritto antecedentemente richiamato (cioè a dire la considerazione in termini di imputabilità dei disturbi dell’affettività e di personalità), indicando la condizione di variabilità dell’umore implicata da disturbo bipolare come potenzialmente escludente o diminuente la capacità di intendere e volere. A tal fine la difesa, censurando la mancata applicazione dell’art. 88 c.p., «richiama tanto le dichiarazioni di VR tanto quelle di AR che, pur non sapendo rispondere alle domande su eventuali patologie sofferte dalla F, hanno riferito di circostanze indicative di disagio psicologico (il primo parla di interventi dell’ASL con la camicia di forza, la seconda riferisce che le condizioni del figlio della donna la mettono in “queste condizioni”)». Nondimeno la sentenza in esame, in ossequio all’insegnamento del Supremo Collegio in merito all’incidenza in termini di infermità dei disturbi dell’affettività, ne rafforza la portata sul versante processuale, statuendo la sufficienza della certificazione Asl – nella specie di disturbo affettivo maggiore di tipo bipolare accompagnato a scompenso psicopatologico – quale indizio idoneo a far dubitare della imputabilità dell’imputato, così “obbligando” il giudicante a svolgere indagini «sull’incidenza che l’accertata patologia poteva avere sui comportamenti tenuti in occasione degli episodi descritti in imputazione». In mancanza di tale doveroso accertamento, la «lacuna inficia la decisione e impone il suo annullamento con rinvio perché si svolga nuovo giudizio al fine di approfondire, con piena libertà valutativa ma con ogni ausilio tecnico di