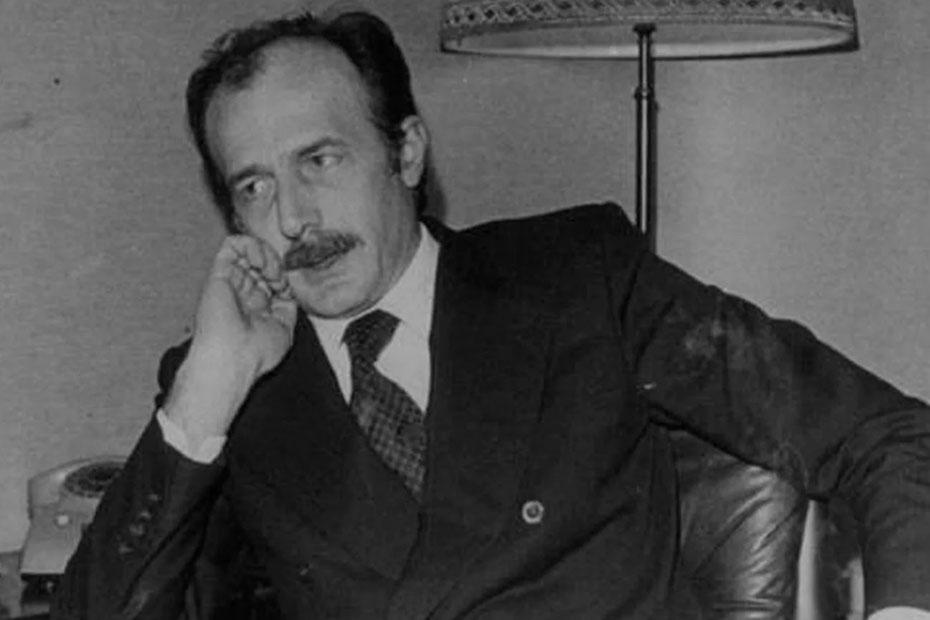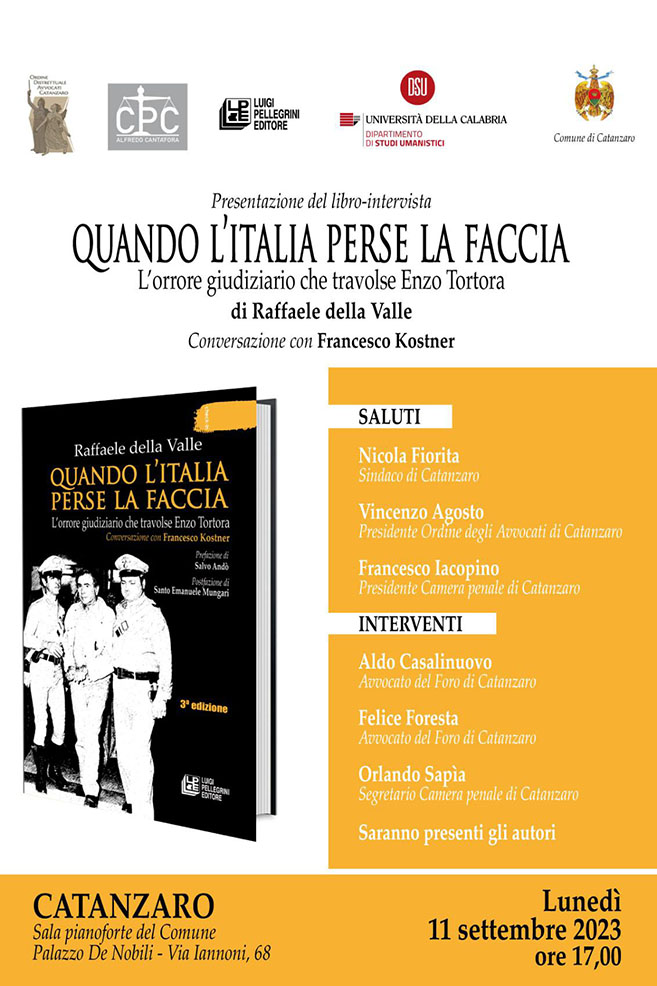Uno Stato minimo nei contenuti sociali e massimo nell’esercizio del potere punitivo
di Alberto Scerbo e Orlando Sapia – Nonostante tutti gli esecutivi e le rispettive maggioranze degli ultimi trent’anni si siano sempre professate assolutamente liberali, hanno in vero realizzato delle politiche in materia di sicurezza in direzione opposta al paradigma garantista di matrice liberale che vorrebbe l’esercizio del potere punitivo da parte dello Stato, ovverossia il potere penale, da considerarsi quale extrema ratio di governo. In compenso, la medesima classe politica, nelle sue poliedriche declinazioni, al netto delle eccezioni imposte da una realtà non facilmente imbrigliabile, si è distinta nel sostenere e realizzare i più spinti propositi di ristrutturazione statale all’insegna del laisser faire, laisser passer. Nel corso degli ultimi decenni, il martellante battere della grancassa sull’interesse primario dell’impresa e sull’idea dello Stato considerato alla stregua di un’azienda, se ha condotto ad un’iniziale presa di coscienza della necessità di un’amministrazione della cosa pubblica secondo criteri anche di economicità, per superare decenni di sperperi, per altro verso ha instaurato un regime di governo improntato sulla prevalenza assoluta dei parametri economici. Dimenticando, però, che il perseguimento del bene comune non si misura semplicemente in termini numerici, perché comprende anche la tutela dei ceti più deboli, l’eliminazione delle sacche di emarginazione, la solidarietà sociale e in modo prevalente l’accesso di tutti ai diritti fondamentali. Con l’effetto per nulla inatteso di un processo di selvaggia privatizzazione di enti e servizi, di un’azione amministrativa rispondente alla logica aziendalistica, di una configurazione dei rapporti di lavoro improntati sulla flessibilità e lo scardinamento delle difese giuridiche, della compressione delle tutele e di un’erosione graduale dello stato sociale. In un contesto così delineato si sono profilati in maniera costante ripetuti tagli in settori evidentemente ritenuti non produttivi almeno nell’immediato. Una visione sicuramente miope degli interessi collettivi, accompagnata dalla mancanza di proiezione verso l’avvenire, ha indotto, così, a mortificare campi nevralgici come la ricerca e la sanità, ma soprattutto ad operare un graduale, ma continuo, taglio della spesa sociale. A questo progressivo arretramento dello Stato sulle politiche sociali a tutti i livelli ha fatto riscontro un incremento delle soluzioni di tipo penalistico, quale rimedio giuridico dei problemi e dei mali sociali. Con l’idea ben precisa di affidare alla materia penalistica un ruolo catartico nei riguardi dell’opinione pubblica. Si sono andate sviluppando, così, le dinamiche tipiche del «populismo penale» che ha ridotto la scelta di criminalizzazione ad una operazione di marketing, in ragione della quale si è avuto un aumento delle fattispecie delittuose e degli edittali di pena, la creazione di tecniche legislative di normazione che comportano l’anticipazione della soglia punitiva e di circuiti di esecuzione penale differenziata. L’esempio più recente è quello annunciato qualche settimana addietro con il comunicato n. 59 del Consiglio dei Ministri, per ora cristallizzato in un disegno di legge approvato dall’esecutivo, in attesa di passare dal vaglio parlamentare, che assai probabilmente lo approverà senza intaccarne la struttura e il finalismo. Tra le novità risaltano la norma che renderà da obbligatorio a facoltativo il differimento pena per le donne incinte e le madri con prole fino a un anno, così aprendo le porte degli istituti penitenziari ai bambini, di certo incolpevoli, al seguito delle madri. Trattasi di una normativa che è stata pensata con particolare riguardo alle donne di etnia rom, così rispolverando vecchie logiche parrebbe ispirate al diritto penale del nemico. Queste innovazioni sono nel solco di quanto già fatto dai precedenti esecutivi, al di là del colore politico. Difatti negli ultimi anni, oltre l’allargamento delle misure di prevenzione con l’introduzione del Daspo Urbano (Decreto c.d. Minniti 2017), sempre suscettibili di nuove applicazioni, come disposto dal Decreto c.d. Caivano, addirittura nei confronti dei minori. Si assiste alla continua creazione di nuove fattispecie punitive, del tutto superflue ad esempio la norma contro i rave party (art. 633 bis), oppure all’aumento delle pene, molto spesso incidendo proprio sul minimo. In questo senso la L. n. 107/2023, c.d. Riforma Orlando, che ha innalzato i minimi delle pene per le fattispecie di rapina, estorsione e furto in abitazione. Reati quest’ultimi contro il patrimonio che sono commessi, molto probabilmente, da soggetti che sono stati risucchiati in quella fascia di povertà assoluta che sempre più si allarga, causata delle crisi cicliche economiche e sociali che hanno investito il paese negli ultimi anni. La risposta dello Stato a questi nuovi poveri, emarginati o espulsi dal ciclo produttivo o che giungono sulle barche della disperazione sulle nostre coste, in fuga da fame, guerra e regime violenti irrispettosi dei diritti umani, al netto di qualche provvedimento ottriato di volta in volta così da calmierare gli animi, è il diritto penale, probabilmente perché, tra gli altri vantaggi, è anche a costo zero, almeno nell’immediato. In modo sistematico si è andato profilando, in tal modo, un vero e proprio diritto penale massimo, che, silenziosamente, ha sfruttato le ansie derivanti dai pericoli avvertiti dalla collettività, per attuare una espansione del potere punitivo, con il coinvolgimento di un numero sempre più ampio di soggetti inseriti nel circuito della penalità. Sotto questo aspetto la pena torna, però, ad essere crudele o forse non ha mai smesso di esserlo e il re è nudo. Il garantismo, nella politica legislativa dell’Italia repubblicana, è durato lo spazio di un mattino, dall’approvazione della prima riforma dell’Ordinamento Penitenziario del 1975 alla riforma del Codice di Procedura Penale del 1989, per poi cedere il passo al mantra della Zero Tolerance. (Pubblicato 8/02/24 in “Studi sulla questione criminale”, Nuova serie dei delitti e delle pene)
Uno Stato minimo nei contenuti sociali e massimo nell’esercizio del potere punitivo Leggi tutto »