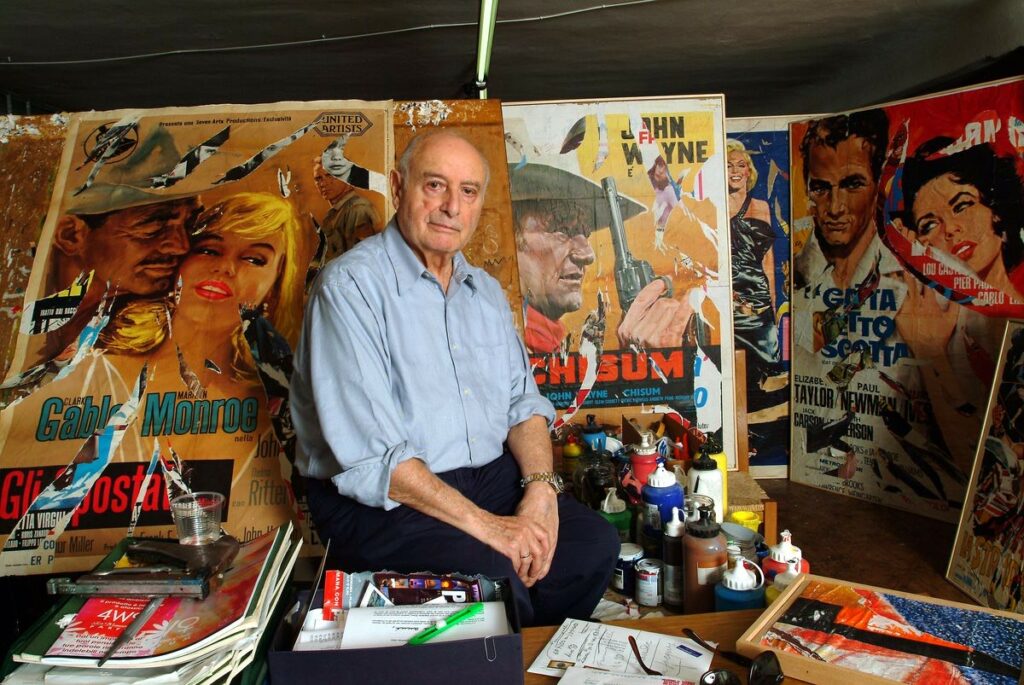L’AZIONE COME STRUTTURA DIALETTICA DI UN CONFLITTO
di Domenico Bilotti* – La più stimolante contraddizione nel vissuto telesiano consiste nella sua afferenza a un mondo di relazioni sociali ancora in gran parte profondamente derivativo, rispetto alla demografia e ai rapporti civili in opera, e nella schietta rivendicazione di un orizzonte di senso meno ipostatizzato e conservatore delle mode del periodo. Ciò certo non fa di Bernardino Telesio un rivoluzionario, sicuramente non nel senso che al lemma hanno attribuito il diritto costituzionale e la dottrina dello Stato negli ultimi due secoli. Ne individua la teoresi, tuttavia, in una interlocuzione critica coi saperi e in una modalità tutta nuova di secondarne la diffusione. Sul piano dell’analisi giuridica serve adesso comprendere se quella spinta controtendenziale abbia avuto, o meno, riflessi empiricamente riscontrabili, nel metodo della discussione giudiziaria e delle sue categorie operative di riferimento. Dal punto di vista redazionale, il De Rerum Natura Iuxta Propria Principia precorre la manualistica dei secoli successivi, anche sul piano della stesura – per altro verso, secondo una modalità di scrittura molto frequente nell’accademia meridionale. Telesio portava con sé una sorta di set di appunti, per le dispute, le lezioni e i dibattiti cui partecipava, e mano a mano certosinamente ingrossava il blocco, conferendogli struttura più rifinita. Il primo libro dell’opera è pubblicato a Roma soltanto nel 1565: da oltre un ventennio, però, era ben nota l’elaborazione telesiana e, almeno dal decennio precedente, sia a Napoli sia in Roma è probabile circolassero appunti e sintesi del più vasto opus telesiano. Che il primo libro monografico dell’A. appaia quando ormai è ultracinquantenne dimostra invero l’ulteriore processo di composizione dell’opera, secondo una sua coerenza interna, ma anche tramite un iter progressivo fatto di revisioni continuative. Il De Rerum Natura è in sostanza (esattamente come per i grandi dottrinari della scienza privatistica nel Novecento) un libro noto quanto ai suoi orientamenti di fondo, ben prima che sia integralmente pubblicato. Probabilmente, anzi, hanno un ruolo a che sia presto edita anche la seconda sezione del volume, solo cinque anni più tardi, a Napoli, le pressioni entusiastiche di un mondo culturale interessato a leggere finalmente a sistema le tesi del filosofo cosentino, non bastando più la singola circostanza oratoria nella quale volta per volta fossero state presentate, nella sede di un dibattito specialistico. È probabile, ancora, che Telesio stesso sia addivenuto a questa decisione per almeno tre ordini di motivi. Il primo, quello più comprensibile agli occhi della posterità, è che avere una fonte ufficiale, scritta e finanche vistata dal suo autore, avrebbe consentito di eliminare interpolazione esterne, garantendo così una più salda e attendibile circolazione della stessa. Su Telesio poi gravavano singolari sospetti per posizioni strutturalmente eterodosse, rispetto alla linea ufficiale del magistero ecclesiastico e alla tradizione teologica che ne sostanziava, nella pratica, la dottrina e il consenso. Da questo punto di vista, come ogni oppositore al sentire comune del suo tempo, che però accetta di non violarne le istituzioni, Telesio è un singolare tipo di umanista, eppure non tanto di nuovo conio. Proviene da una famiglia altolocata, nella quale il rapporto con le autorità ecclesiastiche è sempre stato radicato, risalente e solido. Come si è precedentemente osservato, per quanto non lo fosse in senso stretto, talvolta Telesio era definito dalle fonti un chierico. Se chierico era, tuttavia, lo era soprattutto nel senso storico-etimologico e socio-culturale delle esperienze dei clerici vagantes, a base della nascita del sistema universitario europeo: pensatore itinerante, spirito acceso, di abilità pedagogico-persuasiva. Non invece nel senso strettamente giuscanonistico che ancora modellava lo strumentario intellettuale del giurista di rango, per il tramite dell’utrumque ius nella dottrina privatistica (che a quella straordinaria fase di significazione interordinamentale, tra digesto e corpus, ancora guardava, per formazione, se non per convinzione) e del diritto inquisitoriale nelle procedure criminali. Telesio aveva viepiù prole legittima e una moglie alla quale era affezionatissimo: è lo stato vedovile che rende plausibile la proposta di Pio IV; in assenza di quello, il diritto vigente cinquecentesco avrebbe potuto far qualificare Telesio anche come consigliori ecclesiastico, giammai quale vescovo o porporato. En passant, la tanto vituperata inquisizione, certo esecrabile sul piano delle condanne emesse e delle ragioni giustificative e apologetiche delle medesime, tuttavia fu, alla stregua di quanto oggi notano internazionalisti e processualisti, la prima base per configurare una giurisdizione generale alternativa al primato delle sovranità territoriali. Lì, e ieri, promossa in ragione dell’universalismo teologico; qui, e oggi, legittimata de facto da una governance e da una petizione sui diritti umani non più demandabile alla sola cornice statuale, dove anzi più spesso le violazioni avvengono. Quale che ne sia stato l’impatto, la tardiva pubblicazione del De Rerum Natura è così bilanciamento tra il mantenere una posizione esteriore il più possibile cautelata, rispetto alle rimostranze canoniche, e l’opportunità di rendere però chiaro (senza travisamenti esterni) quanto l’analisi telesiana andava svolgendo e sviluppando. Ed è proponibile un terzo ordine di motivi, per cui finalmente l’inesausto Telesio scelse finalmente di pubblicare i risultati delle sue ricerche e delle sue riflessioni: il fatto, da un lato, che fosse mano a mano più convinto della piattaforma gnoseologica avanzata e che, dall’altro, esistesse ormai sia nell’ambiente partenope, che in quello pontificio un pubblico interessato all’opera. I tempi per la gestazione matura del testo integrale si rivelano, del resto, autenticamente telesiani: il primo volume è del 1565, l’edizione completa è del 1586 – napoletana, e questa è conseguenza biografica. Nel primo periodo romano, la protezione di curia ha un peso; negli ultimi due decenni di vita, sono i nobili Carafa di Nocera a garantire al filosofo favori e consensi. È il periodo nel quale Telesio diventa in un certo senso l’intellettuale di riferimento in un certo tipo di convivi e simposi. Gli sono amici il drammaturgo e numismatico Annibal Caro – nonostante il petrarchista fosse teoreticamente ancora devoto al vetusto verbo aristotelico – e il grande letterato Torquato Tasso, che personalmente consola Telesio per il dramma del figlio ucciso. Perché Telesio non è percepito dalla cultura, prossima, successiva come un fautore del riformismo giuridico? Bisogna ammettere che giurista professionale non è; la sua
L’AZIONE COME STRUTTURA DIALETTICA DI UN CONFLITTO Leggi tutto »